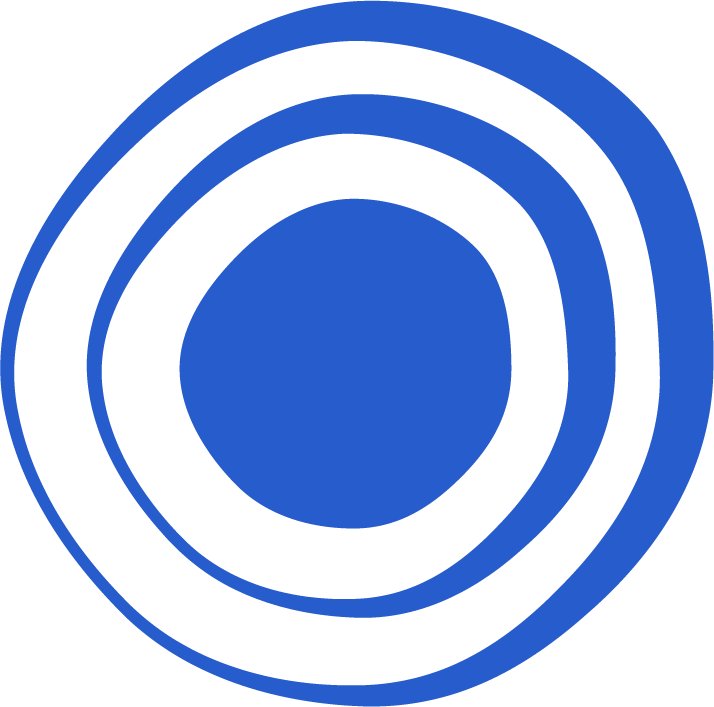Recentemente è stato chiesto a Sean Penn, in piena campagna promozionale, cosa direbbe allo spettatore medio per convincerlo a guardare “Una battaglia dopo l’altra”. Replica: “Assolutamente nulla. Direi semplicemente che si tratta di un film di Paul Thomas Anderson“.
Ora, nonostante il sottoscritto la consideri una risposta più che esauriente, proveremo ad esser un tantino meno laconici della star californiana, per sviscerare qualche elemento in più.
Il film è liberamente tratto da Vineland, romanzo del visionario Thomas Pynchon, autore già trasposto da Anderson (“Vizio di forma”), e trasuda politica da tutti i pori, una politica distante da colletti bianchi e palazzi istituzionali (imperante a queste latitudini), che trova il suo centro gravitazionale nella militanza, che, nella sua deriva più radicale, prende le sembianze della guerriglia rivoluzionaria.
Nulla di sorprendente, considerando la composita società statunitense, da sempre lacerata da violenza e tensioni interne, con l’arte, e il cinema in prima linea, pronta ad attingere a piene mani da un tale maelstrom sociale (solo lo scorso anno usciva nelle sale una pellicola ingiustamente ignorata dai più: Civil War).
Tuttavia, Una battaglia dopo l’altra vince (il consenso dello spettatore) e vincerà (valanghe di premi) perché possiede la capacità, mai troppo celebrata, di non prendersi troppo sul serio, e dissacra, con acume ed ironia, tutti i temi che affronta, suscitando una risata e smuovendo una riflessione, rigorosamente in quest’ordine, senza quella pedante presunzione, alquanto diffusa, tipica di coloro che si arrogano il diritto di insegnare agli altri come si sta al mondo. Certo, l’ottima performance corale del cast aiuta allo scopo, tuttavia è la scrittura dei personaggi a colorare così vivacemente (per qualcuno anche troppo) la pellicola: un assortimento di maschere, che sì, sfiorano il topos, e le cui azioni, talvolta, sono figlie di scelte narrative vagamente edulcorate o autoindulgenti, ma è un vizietto che si può perdonare; d’altronde, come ricordava Gaber, gli americani, quando vogliono fare gli anti-americani, finiscono per essere ancora più americani.
Topoi, dicevo. Ergo, c’è spazio per tutto: si parla di suprematismo razziale, del grottesco paradosso che prende il nome di burocrazia, delle immarcescibili idee “a prova di proiettile”, della volatilità del concetto di “famiglia”.
Ma, soprattutto, si parla di conflitto generazionale. In un mondo di adulti infiacchiti e istupiditi, se non ripugnanti (il film non è molto clemente coi boomers), c’è, infatti, un esercito di giovani che, malgrado sia spesso incompreso e incomprensibile, non aspetta altro che raccogliere il testimone da chi, pur avendo combattuto a lungo la propria battaglia, deve accettare che, più prima che poi, gli toccherà ritirarsi nelle retrovie, lasciando spazio alla freschezza e alla vivacità ora espresse da chi deve insegnargli come scattare una foto con lo smartphone. Reale convinzione nella concretezza delle nuove generazioni o fantasia di un sognatore che non vuole soccombere al disincanto?
Ne riparliamo (forse) fra una ventina d’anni.
Insomma, black comedy, affilata satira sociale, action-movie tachicardico. Una ricca zuppa dal sapore deciso, quindi divisiva, opera di un cuoco geniale e un po’ megalomane. In conclusione, perché dovreste guardare Una battaglia dopo l’altra? Perché è un film di Paul Thomas Anderson, naturalmente.